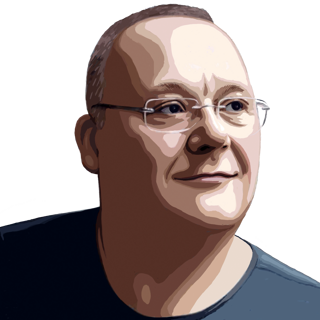Sul sito del comando regionale dell’esercito israeliano c’è scritto che un terremoto o un missile possono causare un attacco di panico, uno svenimento o un infarto. In altre parole, anche senza che le persone siano ferite, la paura e il terrore possono avere conseguenze fisiche. Ma secondo le forze armate israeliane non c’è alcun collegamento tra la morte per arresto cardiaco di Rayan Suleiman, un bambino di sette anni deceduto il 29 settembre, e i soldati che hanno fatto irruzione in casa sua nel villaggio di Taqua. “Non è stata trovata alcuna prova di una caduta di Rayan o di danni che avrebbe subìto a causa dell’attività dell’esercito israeliano”, ha dichiarato il portavoce delle forze armate dopo un’inchiesta interna. Secondo i militari solo i danni fisici possono essere collegati alla morte dei palestinesi. E secondo gli israeliani non c’è alcun legame tra la capacità dei soldati di fare del male e il terrore che un bambino palestinese prova alla loro semplice vista.
La paura è la naturale compagna di chi vive sotto l’occupazione militare. Ma ci sono situazioni in cui il terrore è scatenato in maniera consapevole e intenzionale, sparando. È successo durante una manifestazione alla periferia sud di Nablus, il 28 settembre. Se si fosse svolta in Bielorussia o in Iran, i mezzi d’informazione statunitensi e israeliani l’avrebbero definita un atto di eroismo. Il fotografo Nidal Shtayyeh è stato il primo ad arrivare sulla scena per documentarla. Shtayyeh è rimasto a decine di metri dai soldati e dai manifestanti, che bruciavano pneumatici e lanciavano pietre. Aveva l’elmetto, la maschera antigas e un giubbotto antiproiettile con la scritta “stampa”. Un soldato ha puntato il fucile e ha colpito la gamba di Shtayyeh con un candelotto di gas lacrimogeno. Non ditemi che non l’ha fatto apposta.
La paura è la naturale compagna di chi vive sotto l’occupazione militare israeliana. Ma ci sono situazioni in cui è scatenata in maniera intenzionale
Nel frattempo altri due fotografi sono arrivati e si sono fermati lontano dai manifestanti, che scappavano dai lacrimogeni. Shtayyeh ha continuato a filmare, nonostante il dolore: in seguito si è saputo che aveva una tibia incrinata. I soldati si sono avvicinati ai suoi colleghi. Un militare ha dato una spinta a un fotografo. Poi un altro ha lanciato una granata lacrimogena. Per diversi minuti Shtayyeh e il suo collega non sono riusciti a reagire: circondati dai gas lacrimogeni, stavano soffocando. Non ditemi che i soldati non hanno visto che erano fotografi. Nel 2015 Shtayyeh ha perso la vista dell’occhio sinistro dopo che un soldato gli ha sparato un proiettile di metallo rivestito di gomma durante una commemorazione della nakba, la “catastrofe” per i palestinesi, coincisa con la nascita di Israele nel 1948 e l’esodo di centinaia di migliaia di loro.
Questo articolo avrebbe dovuto concludersi qui, con alcune domande sui gas lacrimogeni: i soldati si sono divertiti a usarli? C’era forse l’ordine di intimidire i fotografi palestinesi? Ma poi sabato 8 ottobre l’esercito israeliano ha invaso di nuovo Jenin. Con la gamba ancora dolorante, Shtayyeh e altri tre colleghi palestinesi hanno raggiunto una piccola stanza sul tetto di un edificio ai margini del campo profughi. Uno si è messo vicino alla finestra e ha notato che giù c’erano alcune jeep militari. Improvvisamente ha spinto Shtayyeh a terra, gridando: “Ci stanno sparando”. Si è lanciato sugli altri due fotografi, mentre quattro proiettili colpivano il cavalletto e la macchina fotografica. Una precisione degna dei corpi scelti dell’esercito israeliano o di Yamas, un’unità speciale della polizia di frontiera. L’elmetto di Shtayyeh è rotolato sul tetto. Il fotografo si è messo rasoterra per riprenderlo. Uno dei suoi colleghi l’ha seguito. La sparatoria è ricominciata. Uno o più cecchini hanno sparato su di loro almeno altre due raffiche. Un proiettile ha colpito il tetto proprio accanto alla testa di Shtayyeh. I fotografi non si sono più mossi e dopo ogni sparo si chiedevano se qualcuno fosse stato colpito. Hanno chiesto aiuto al telefono, gridando. Le loro chiamate sono state poi diffuse dai mezzi d’informazione palestinesi. È stata una mezz’ora di puro terrore, fino a quando le forze militari se ne sono andate. I fotografi pensano che volessero ucciderli.
Il regime israeliano non può trattenersi dal seminare paura e terrore. Ma Shtayyeh, come i suoi colleghi, continuerà a correre rischi e a lavorare perché, come dice lui stesso, “ho dei figli all’università”.
Dopo l’episodio i portavoce dell’esercito israeliano e la polizia hanno rilasciato queste dichiarazioni: “Non siamo a conoscenza di accuse di spari contro la stampa. I soldati non prendono di mira chi non combatte, giornalisti inclusi. Il caso in questione si riferisce a un’operazione in un campo profughi a Jenin, durante la quale ci sono stati scambi di fuoco tra le forze dell’esercito israeliano e i palestinesi armati, e i soldati sono stati presi di mira da diversi punti. Con la loro presenza in una zona di combattimento, i civili non combattenti mettono in pericolo la loro vita”. ◆ ff
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1482 di Internazionale, a pagina 44. Compra questo numero | Abbonati