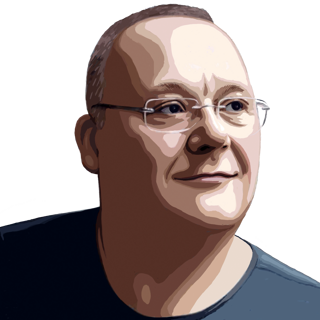Il 7 ottobre 2023 una parte del mondo arabo ha celebrato l’attacco di Hamas come una storica vittoria contro il nemico. Nonostante le atrocità commesse dal gruppo islamista, malgrado l’ondata di violenza che avrebbe poi subìto la popolazione di Gaza per rappresaglia (prevedibile fin dal primo giorno), il fallimento dei servizi di sicurezza israeliani è stato presentato come uno spartiacque storico in questo conflitto che va avanti da più di settantacinque anni.
Sette mesi dopo, Gaza è un cimitero a cielo aperto. Sono stati uccisi circa 35mila palestinesi, di cui quasi la metà bambini. Il territorio è una distesa di rovine. Tutto o quasi è stato distrutto. Tuttavia, una parte del mondo arabo continua a parlare di “vittoria”. E considera ancora che la morte di quindicimila bambini sia il “prezzo da pagare” per sconfiggere il nemico. E continua ad affermare in ogni sede che il futuro per i palestinesi sarà migliore e che Israele sarà sconfitto.
Il sostegno allo stato ebraico è ai minimi storici. Hamas, invece, oggi è più popolare che mai in tutto il mondo arabo, a eccezione forse proprio di Gaza. Non c’è da rallegrarsi di questa situazione
Potrebbero aver ragione? Può nascere qualcosa di positivo da tutto questo orrore? Si fatica a crederlo. La storia chiaramente non è cominciata il 7 ottobre. E questo attacco, per quanto terribile, è anche il risultato della politica israeliana degli ultimi trent’anni. Ma il diluvio di Al Aqsa, come Hamas ha chiamato gli attentati di ottobre, ha sfondato le porte dell’inferno e non è chiaro cosa a breve termine potrà chiuderle.
Gli estremisti su tutti i fronti hanno il vento in poppa e non emerge neppure una piccola prospettiva di uscita dalla crisi. Più che mai, dal punto di vista di entrambi gli schieramenti, la soluzione passa per la distruzione totale dell’altro. Se non fosse che uno dei due, Israele, resta di gran lunga più forte dell’altro.
Nulla oggi fa pensare che la quotidianità dei palestinesi possa migliorare nei prossimi mesi e anni. Né a Gaza né in Cisgiordania. Tutt’altro. Bisogna però far notare due cose: la prima è che il 7 ottobre ha cambiato le cose, pur senza modificare radicalmente la situazione. La seconda è che Israele non è mai sembrato così fragile.
La questione palestinese era svanita. Oggi è al centro dei dibattiti, eclissando talvolta perfino la guerra in Ucraina e la rivalità tra Cina e Stati Uniti. L’11 maggio 143 paesi hanno votato per l’adesione dello stato palestinese all’Onu e le cancellerie occidentali evocano nuovamente la soluzione dei due stati. Nei campus statunitensi, e in misura minore in quelli europei, si organizzano manifestazioni filopalestinesi. Potremmo essere di fronte a una frattura generazionale.
Israele ha perso la battaglia della comunicazione. E ha perso pure la battaglia diplomatica, anche se non tutte le voci e non tutti i voti sono uguali dentro l’assemblea delle Nazioni Unite, dato che gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione.
Infine, cosa molto più inattesa, lo stato ebraico sta perdendo la battaglia militare. Dopo sette mesi la prima potenza regionale non è riuscita a eliminare i battaglioni di Hamas. E il suo principale alleato minaccia, attraverso la voce di Joe Biden, il presidente più sinceramente filoisraeliano della storia statunitense, di non fornirgli più armi offensive se insisterà a voler invadere la città di Rafah.
Israele è additato come uno stato paria, paragonato al Sudafrica dell’apartheid. È accusato da militanti, studenti, ma anche da stimati esperti, di commettere un genocidio. Lo stato ebraico è isolato, la sua immagine è seriamente compromessa, la sua leadership in rovina. Non ha nessuna proposta seria da esporre né per mettere fine alla guerra né per costruire la pace.
Il sostegno a Israele è ai minimi storici. Hamas, invece, oggi è più popolare che mai in tutto il mondo arabo, a eccezione forse proprio di Gaza. Ma non c’è affatto da rallegrarsi di questa situazione. Da un lato perché sia Hamas sia la leadership israeliana – ben oltre l’attuale primo ministro Benjamin Netanyahu – sono ormai intrappolati in una logica di guerra di lunga durata. Dall’altro lato perché la realtà sul campo può cambiare nel giro di una settimana. E se c’è una cosa che va sempre tenuta a mente di tutti i drammi che ha vissuto il Medio Oriente in questi ultimi decenni, è che alla fine della partita contano solo i rapporti di forza. ◆ fdl
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1563 di Internazionale, a pagina 38. Compra questo numero | Abbonati