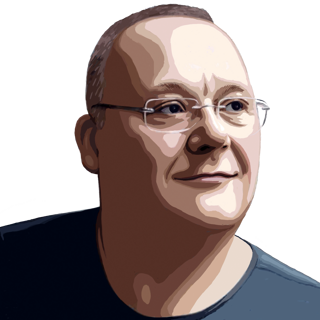E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? Era una soluzione, quella gente”. Recita così una poesia di Konstantinos Kavafis. Noi turchi abbiamo i nostri barbari e vogliamo liberarci di loro per risolvere tutti i problemi. Se andassero via, in Turchia si sistemerebbe tutto! Immigrati, rifugiati, siriani, arabi. Se fossero spediti via, le rive del mar di Marmara non verrebbero fatte esplodere con la dinamite e non ci sarebbero donne uccise ogni giorno; il prezzo del formaggio scenderebbe e questo paese triste ed esausto troverebbe una prosperità infinita.
Ma una cosa va detta. Poche persone tra quelle che accusano di razzismo chi si lamenta per gli immigrati rischiano di perdere la casa o il lavoro a causa loro. Giornalisti, professori, intellettuali, chi di noi è costretto a vivere a contatto con gli immigrati? Guardare “i barbari” da lontano è un nostro lusso. Quindi non so se sia sensato parlarne. Gli immigrati non hanno colpa di questa situazione, semmai ce l’ha il potere che li usa come merce di scambio. Viviamo tutto questo a causa di un governo che gestisce il paese come una cosa senza importanza. Ma del resto i pesci piccoli, nel momento in cui capiscono di non poter mangiare quelli più grandi, mangiano quelli ancora più piccoli. E così “manderemo via tutti” diventa uno slogan elettorale. Al tempo stesso si dimentica una cosa: siamo tutti potenzialmente dei barbari. Ecco la mia storia da barbara, fresca fresca.
I turchi vogliono liberarsi dei rifugiati. Ma gli immigrati non hanno colpa di questa situazione, semmai ce l’ha il potere che li usa come merce di scambio
Il 1 giugno mi sono alzata alle sei per prendere un treno da Amburgo a Berlino. Era la terza volta che andavo nella capitale tedesca per ottenere un visto per il Regno Unito. Siccome non c’è una via d’uscita dal labirinto digitale che hanno creato, l’unico modo per scoprire il proprio destino è andare di persona all’ufficio dei visti. Entrare è vietato. Un giovane gentile che si affaccia ogni cinque minuti ti fa sapere se il Regno Unito ha deciso di darti o meno il visto. Ogni volta che esce, le persone sono divise in due gruppi: “Chi viene dall’Ucraina a destra, prego. Gli altri a sinistra”. Da quando Londra è uscita dall’Unione europea, le cose non funzionano, lo sappiamo tutti. Ma di fronte a questa porta ci sono persone che come me aspettano il visto da otto settimane. Ci riuniamo qui come fuoriusciti dal terzo mondo e aspettiamo insieme. La maggior parte delle persone arrivate dall’Ucraina sono madri con figli. Probabilmente alloggiano in un hotel da otto settimane, visto che profuma tutto di shampoo da albergo. Io aspetto con i neri africani. Facce tirate, rassegnate al fatto che non saranno mai accettate in questo mondo bianco. Quanti siriani in Turchia capiscono che si parla di loro come di una massa senza nome? Mi viene in mente la conversazione avuta con un nero in un campo profughi al confine tra Tunisia e Libia. “Avete dell’acqua? Da mangiare?”, gli chiesi. In un perfetto inglese mi rispose sorridendo: “Non le viene in mente che possa avere un curriculum, vero?”. Era un insegnante. Dalla vergogna gli regalai la mia penna.
Alla porta dell’ufficio dei visti una madre ucraina grida in un inglese stentato : “Stanotte dormirò qui! Aspettiamo da otto settimane. Ci espelleranno da questo paese!”. E questi sarebbero i profughi accolti meglio degli altri. “Deve dire grazie, chi viene dall’Africa è mandato in un campo profughi in Nigeria e aspetta per mesi”, dice l’uomo al mio fianco. Quando il pesce piccolo non riesce a spiegare il suo problema a quello grande, compete con gli altri piccoli come lui. Quando la donna grida, l’incaricato alla porta chiede scusa. “Non dipende da noi”, dice.
Finalmente ridanno il passaporto a un uomo nero. L’ho già visto tre volte, la prima tre mesi fa. Lo prende con calma, come una cosa di poco conto. Si sposta sul marciapiede di fronte, raggiunge l’amico che lo sta aspettando e cominciano a saltellare in mezzo alla strada. Iraniani, siriani, indiani continuiamo ad aspettare. Tutti guardiamo verso il marciapiede opposto, verso i due neri che saltano. Lo dessero anche a noi, anche noi salteremmo. Infine, dopo otto settimane e sette ore di attesa, ottengo il visto. Abbraccio l’incaricato alla porta. Lui è così sorpreso che, non sapendo cosa fare, si mette a ridere. In confronto alle persone finite in un campo profughi, costrette a fuggire dalla guerra con i figli o ad attendere un visto senza soldi in tasca in una città sconosciuta, sono una privilegiata. Eppure per dimenticare l’umiliazione devo inghiottire saliva per mezza giornata.
Restare senza casa somiglia a una vertigine. Chi non l’ha vissuto non può capire. Come ha detto Shakespeare, l’esilio è peggio della morte. Noi turchi ci sentiamo come se la nostra casa fosse stata bruciata e non abbiamo molto affetto da offrire. Ma se anche restassimo tutti senza casa, dovremmo ricordarci che abbiamo tutti un curriculum, una storia di vita. Peccato che i miei incontri siano coincisi con un brutto momento, altrimenti forse avremmo avuto un po’ di tempo per raccontarci le nostre storie. ◆ ga
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1465 di Internazionale, a pagina 44. Compra questo numero | Abbonati