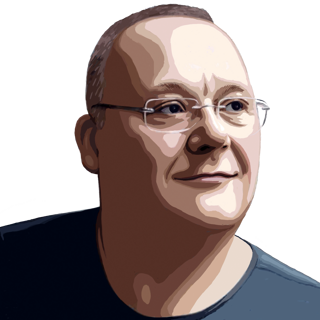“Lasciatemi divertire”, diceva l’ottimo Aldo Palazzeschi. E non sono pochi i grandi artisti che si sono molto divertiti e molto consolati con il loro lavoro, soprattutto nel mondo dello spettacolo, ricavandone fama, denaro e onori. Uno fu Sacha Guitry (1885-1957), scrittore e commediografo, attore e regista, capocomico attivissimo in Francia dagli anni venti del novecento fino alla morte. Nacque a San Pietroburgo, in Russia, dove il padre Lucien recitava, e fu chiamato Alexandre, da cui il vezzeggiativo russo di Sacha, con il quale conquistò la fama.
Scrisse circa centoventi commedie e ne mise in scena più o meno altrettante, da dominatore dei teatri dei boulevard, adulato e viziato dalla borghesia del tempo. Tra i suoi amori ci fu Yvonne Printemps, cantante e attrice di valore, nota interprete di Offenbach, che gli fu soffiata da Pierre Fresnay, anche lui attore celebre e “di classe”.
Siamo di fronte al racconto in prima persona della vita e della carriera di un “libertino”, che ha scelto come campo d’azione e trampolino di lancio Montecarlo e il suo casinò
Il cinema di Guitry, in particolare quello degli anni trenta, è un cinema dove domina la parola, un cinema “da boulevard”, decisamente teatrale e “parigino”. Ebbe pochi ammiratori tra i critici cinematografici (ricordo in Italia un tempo in cui si era in pochissimi ad apprezzarlo, con Tullio Kezich, Paolo Mereghetti e Roberto Santachiara) anche perché rivalutato dai Cahiers du cinéma, sotto la spinta di François Truffaut, fedeli alla politique des auteurs. I Cahiers a poca distanza di tempo rivalutarono un altro grande del teatro, ma questo molto marsigliese, Marcel Pagnol, autore di alcuni film molto belli, e meno teatrali di quelli di Guitry per la loro scelta del plein air.
Nell’opera di Guitry, si diceva, la parola è al centro, e si assiste a un fuoco di fila di battute argute che pretendono a un’ascendenza (e a una profondità, più difficile da raggiungere) di stampo molieriano. Ma Guitry dimostra una sapienza nel metterla in scena che ben pochi hanno avuto.
Con il tempo si appesantì, lui che tra teatro a cinema aveva raccontato Mozart, Pasteur, Debureau, Maria Malibran, Franz Hals e Talleyrand, realizzando film con tanti attori che volevano essere carrellate di storia patria su Versailles e su Parigi e sulle lunghe avventure del Napoleone pubblico e privato. In uno di quei film, Orson Welles, che ammirava Guitry, interpretò l’ambasciatore Hudson Lowe, mentre von Stroheim si prestò a fare Beethoven.
Uomo di spettacolo, Guitry fu anche scrittore, eccellendo nel racconto veloce e brillante, sostanzialmente cinico come peraltro tutto il suo lavoro. Il suo Memorie di un baro (1935, diventato in seguito anche un film con il titolo Il romanzo di un baro), ottimamente tradotto, punteggiato da disegni dell’autore e accompagnato da un breve e denso saggio di Edgardo Franzosini, si legge ancora con molto piacere, e fa venire voglia di rivedere il film che Guitry girò sulla scia del successo del libro. Siamo di fronte al racconto in prima persona della vita e della carriera di un “libertino”, che ha scelto come campo d’azione e trampolino di lancio Montecarlo e il suo casinò.
Alle spalle del baro, figlio di una famiglia numerosa decimata dopo aver mangiato dei funghi velenosi – lui è sopravvissuto perché era in punizione per qualche marachella e dunque non era degno di assaggiarli –, c’è una società estremamente classista, dove farsi strada non è facile ma dove, aguzzando soprattutto la capacità di vedere e giudicare le altrui debolezze, di impadronirsene “recitandole”, è possibile scoprirne pian piano i meccanismi e le vanità, e approfittarne a dovere. In questo senso, le Memorie di un baro sono, non è un paradosso, un libro pienamente attuale: le “qualità” di questo baro appartengono a molti personaggi di successo della politica e dell’economia, del giornalismo e dello spettacolo. Oggi e proprio oggi o, come sarebbe meglio dire, oggi come ieri. Anche nel nostro paese e forse qui più che altrove.
Il confronto con la malattia del gioco e dell’azzardo – su cui Guitry dice cose importanti e plausibili, perché grande osservatore delle passioni e perché ha attraversato tentazioni affini – è forse meno profondo di come l’hanno raccontata Dostoevskij o Joseph Roth e tanti altri. Ma non è meno intrigante. Perché la base è quasi obbligatoriamente filosofica: una riflessione sul caso e sul destino. Questioni non da poco e niente affatto invecchiate. ◆
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1488 di Internazionale, a pagina 85. Compra questo numero | Abbonati