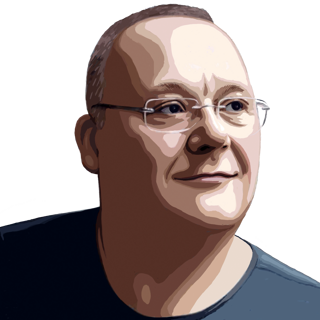La morte di mio padre è una storia che ha molte versioni. Nella prima stesura, che ho letto e a cui ho contribuito, si confondono le trame che man mano abbiamo elaborato: erano i reni, il polmone destro o sinistro, forse il fegato? Abbiamo raccontato la realtà così raramente che ha perso il carattere di esattezza, se non nel senso di vergogna e imbarazzo che ancora aleggia sulla verità. Questi stessi sentimenti confondono, quando non rimuovono, il ricordo che Giulia Scomazzon ha di sua madre, morta nel 1995 nel vicentino per complicazioni legate all’aids. Passando dalla prima alla seconda persona (“Il linguaggio è uno sforzo di distanziamento dall’altro, per questo nasce prima il tu e poi l’io”), l’autrice compone un racconto autobiografico che alterna una scrittura metaforica e intimista a una scientifica e divulgativa, dando al testo un ritmo interessante. In questa ricerca fuori fuoco – della memoria storica, della madre, dell’infanzia – Scomazzon cerca di dissociarsi dall’idea di trauma come performance, “come una gabbia che separa e isola” e, quindi, dalla letteratura del trauma, spesso individuale. La paura ferisce come un coltello arrugginito (peccato per il titolo) non guarda alla memoria così vicino da non vedere gli altri né così lontano da rendere oggettivo il soggettivo: collettivo e individuale, vero e pieno di dubbi. ◆
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1496 di Internazionale, a pagina 84. Compra questo numero | Abbonati