Insieme a una larga fetta del genere umano, dopo mesi di reclusione io e mia moglie rischiavamo un crollo mentale. Entrambi eravamo alle prese con i postumi del covid. L’insonnia non mi faceva dormire per giornate intere. E i sintomi erano aggravati dal trauma per la perdita di un parente stretto a causa del virus. Così un bel giorno abbiamo deciso di cercare un posto dove riprenderci un po’.
Non ti sorprenderà scoprire, caro lettore, che non è stato facile trovare una destinazione adatta nel bel mezzo della pandemia. La Georgia era uno dei pochi paesi dove si poteva andare e dove gli alberghi e i centri benessere erano ancora aperti. Così, come generazioni di cittadini sovietici e post-sovietici prima di noi, abbiamo deciso di fare le cure termali in un sanatorio. Siamo partiti da Kiev proprio mentre i russi rafforzavano la loro presenza militare al confine con l’Ucraina. Come il paese che stavamo lasciando, anche quello dove eravamo diretti si trovava sotto la parziale occupazione russa, invischiato in una crisi politica apparentemente senza via d’uscita. Il principale responsabile di quella crisi era seduto dietro di me sull’aereo. Mikheil Saakashvili, ex presidente in esilio della Georgia e perfetto hipster internazionale, indossava jeans attillati, occhiali da sole aviator, felpa nera con cappuccio e un orribile paio di scarpe da ginnastica. Sui social network ho rapidamente scoperto che quelle voluminose scarpe rosse di Prada costano quanto il mio affitto mensile in un bel quartiere di Parigi.
Anni prima, quando era stato nominato governatore della regione ucraina di Odessa, su Foreign Policy lo avevo accusato di comportarsi da demagogo. Quando sull’aereo mi sono presentato di nuovo e gli ho chiesto quali fossero i suoi piani, Saakashvili mi ha risposto che voleva continuare a battersi contro tutti. L’espressione rabbiosa del suo volto suggeriva che in quel “tutti” ero incluso anch’io. Gli ho augurato buona fortuna e lui mi ha consigliato di godermi la “sua” Georgia.
Il nostro volo è atterrato all’aeroporto di Tbilisi intorno a mezzanotte. Gela, l’autista che ci aveva portati in giro durante i nostri precedenti viaggi in Georgia, ci aspettava all’uscita del terminal e ha subito tirato fuori dal bagagliaio dell’auto una bottiglia di vino rosso fatto in casa.
Niente politica
L’autostrada che porta in città era deserta. Arrivando in albergo ci siamo imbattuti nella conclusione di una chiassosa manifestazione nazionalista contro Vladimir Pozner, un giornalista televisivo russo-statunitense, storico apologeta dell’Unione Sovietica. Davanti all’albergo dove stava festeggiando il suo ottantasettesimo compleanno la folla protestava, sventolando bandiere della Georgia. I patrioti georgiani lo accusavano di essere un “uomo della propaganda russa” e di non aver mai accettato il fatto che la Georgia sia un paese sovrano. Pozner non si aspettava un’accoglienza del genere, e la mattina dopo è partito con un aereo privato.
Come Pozner, una parte dell’élite politica russa non ha ancora capito quanto sia profondo il risentimento causato dalla guerra russo-georgiana del 2008, che ha portato all’occupazione di un quinto del territorio della Georgia. Ho pensato che la manifestazione contro Pozner fosse materiale adatto per un articolo, ma mia moglie mi ha categoricamente vietato d’impegnarmi in qualsiasi attività giornalistica. “Siamo appena arrivati e stai già buttando tutto in politica”, mi ha detto. Poi mi ha ricordato che le poche volte che gli avevo parlato al telefono, Pozner era stato gentile con me. Non sarebbe stato corretto unirmi ai manifestanti che gli lanciavano uova contro la finestra.
Le nostre giornate iniziavano alle 8 del mattino con le lezioni di respirazione cinese
La mattina dopo, mentre Pozner fuggiva verso la sua casa di Mosca, noi siamo partiti per Borjomi, una città termale immersa nelle colline della regione del Samtskhe-Javakheti. Come succede ancora oggi, le sue acque dai poteri terapeutici quasi magici attiravano i Romanov e gli altri nobili russi già nell’ottocento.
Questa cittadina di diecimila abitanti oggi è nota soprattutto per la sua acqua minerale, imbottigliata in un paio di fabbriche quasi interamente automatizzate. La versione sorgiva di quest’acre liquido si può bere gratuitamente da un pozzo che si trova nel mezzo del parco cittadino. L’acqua, che sgorga da un profondo ruscello sotterraneo, odora di zolfo ed è così ricca di minerali che a berla sembra d’inghiottire un distillato di rocce vulcaniche. L’aria di montagna è fantastica e la città conserva uno degli ultimi sanatori sovietici.
Queste strutture erano molto spesso dei veri gioielli architettonici costruiti nel tipico stile degli anni sessanta, ma la maggior parte è stata chiusa o è andata in rovina. Dei pochi sanatori rimasti attivi, alcuni sono stati convertiti in hotel o stazioni termali che hanno poco a che vedere con i centri che un tempo fornivano ai lavoratori sovietici terapie all’ozono, docce terapeutiche, massaggi linfodrenanti e altri stravaganti rimedi in pacchetti vacanze statali “tutto incluso”. Ai tempi dell’Unione Sovietica i buoni per un soggiorno in sanatorio erano distribuiti sulla base di conoscenze e simpatie. Chi non aveva i contatti giusti doveva aspettare anni o ricorrere al baratto per una vacanza alle terme.
Scommetto che tra qualche decennio nessun vecchio sanatorio sarà ancora in piedi. Per questo ho deciso di visitarne uno finché ero in tempo. Per spirito nostalgico e anche perché sono economici.
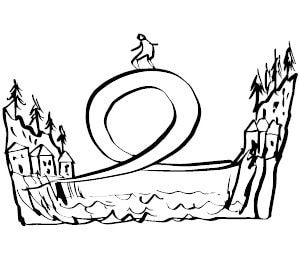
Il Borjomi palace hotel è un edificio di cinque piani giallo e marrone, che svetta su uno sperone di roccia sopra un’ansa del fiume Mtkvari. Inizialmente ospitava la guardia dei Romanov. In epoca sovietica diventò un sanatorio militare ed è stato convertito all’uso civile una decina d’anni fa. L’estetica della struttura combina il minimalismo sovietico con le pacchiane ristrutturazioni dorate tanto amate nei paesi ex comunisti.
Nella sala da pranzo e nella hall l’elemento d’arredo più elegante sono i lampadari in vetro satinato e i candelieri di cristallo. L’atrio è stato ristrutturato con dubbio gusto e i corridoi sono stati tinteggiati di ocra. Dopo il check-in c’è la visita medica. Quando gli ho confessato che avrei voluto perdere i chili presi durante l’isolamento, il responsabile del centro mi ha detto che era fuori discussione. “Qui? Mai! Come si fa a dimagrire mangiando i nostri squisiti khachapuri e khinkali? Può scordarselo!”.
In effetti i piatti del ristorante dell’albergo erano ottimi e fortunatamente immuni alle mode salutiste, ancora sconosciute nel Caucaso. Alla fine del nostro soggiorno, dopo aver stretto amicizia con la mia esile moglie, diverse infermiere le hanno chiesto con discrezione consigli per dimagrire. Al suo suggerimento di abbandonare la dieta nazionale a base di focaccia al formaggio si sono risentite.
Sale e vapore
Le nostre giornate cominciavano alle 8 del mattino con le lezioni di “respirazione cinese” guidate da Jakov, un istruttore che indossava una giacca nera in stile presidente Mao decorata con fibbie di seta bianca. Gli esercizi si svolgevano in una veranda davanti a una grande pagoda, al ritmo di una rivisitazione in chiave techno del tema dell’Ultimo dei mohicani.
Dopo colazione passavamo quattro o cinque ore facendo la spola tra i vari trattamenti e percorsi terapeutici, alcuni dei quali davvero piacevoli: massaggi, ossigenoterapia, elettrostimolazione. L’applicazione di paraffina fusa sul corpo doveva servire a espellere le tossine.
Altri trattamenti in occidente sarebbero considerati piuttosto esoterici. Una volta, per esempio, mi hanno infilato in una tuta spaziale gonfiabile piena di ozono, con un’infermiera che di tanto in tanto buttava un occhio per chiedermi se ero già volato su Marte. Mi piaceva stare chiuso dentro una bolla a forma di capsula spaziale e i fori per le braccia mi permettevano di leggere un libro. Tuttavia l’utilità di trascorrere venti minuti in una sacca a forma di vongola gigante piena di gas ancora mi sfugge. Volendo ci si poteva anche sottoporre a un clistere di “sostanza Borjomi”, seguito da una sessione nella doccia idromassaggio.

◆ Il viaggio Se si arriva da un paese dell’area Schengen per entrare in Georgia basta la carta d’identità. Al momento è anche necessario essere vaccinati contro il covid-19. Il prezzo di un volo dall’Italia parte da 140 euro a/r (Pegasus, Wizzair, Turkish Airlines). Per raggiungere Borjomi da Kutaisi e Tbilisi ci sono numerosi pullman e taxi collettivi al giorno.
◆ Dormire Il Borjomi palace hotel offre stanze doppie a partire da sessanta euro a notte.
◆ Mangiare La cucina georgiana è molto ricca e interessante. Tra i piatti tradizionali ci sono i khinkali, grandi ravioli di carne, il khachapuri, una pizza ripiena di formaggio, gli spiedini alla griglia, mtsvadi, e il satsivi, pollo in salsa di noci.
◆ La prossima settimana Viaggio in Cornovaglia. Ci siete stati? Avete consigli su posti dove mangiare, dormire, libri? Scrivete a: viaggi@internazionale.it.
Nella routine giornaliera era inclusa una mezz’ora nella stanza del sale, una caverna con il pavimento ricoperto di sale e stalattiti di sale artificiale che pendevano dal soffitto. Lì faceva freschetto, così mi allungavo su una sdraio sotto spessi strati di coperte, bevendo un frappè a base di “ossigeno puro”. Non ho idea di quale fosse lo scopo della stanza del sale, ma era un ottimo posto per leggere.
Le relazioni sociali tra gli ospiti del sanatorio somigliavano a una replica della vita nell’Unione Sovietica. Oltre a qualche georgiano, i pazienti erano soprattutto russi e centroasiatici, e la lingua franca era il russo. Persone così diverse, provenienti da quindici paesi, fraternizzavano con grande naturalezza, generosità e gentilezza. Al contrario, nel più tipico spirito collettivista, il concetto di privacy era del tutto sconosciuto. Eravamo continuamente costretti a prendere parte ad attività sociali e incontri con persone di cui non c’interessava granché. Personalmente tutta quella socialità mi divertiva e mi affascinava, ma faceva inorridire mia moglie, che è ucraina e ha vissuto in Unione Sovietica più a lungo di me. Il peggior esemplare del gruppo era un insistente e odioso contadino kazaco di nome Bulat, panciuto e ridanciano patriarca di una fattoria collettiva che si vantava di gestire con il pugno di ferro.
Una mattina, mentre oziavo nella stanza del sale, l’insistente agricoltore mi ha trascinato in una conversazione che non sembrava finire mai, nonostante le mie numerose educate proteste. Ascoltare Bulat che spiegava il funzionamento del sistema della mezzadria al confine russo-kazaco aveva il suo fascino. Ma doversi sorbire le sue barzellette antisemite era molto meno divertente. Le sue gioviali provocazioni continuavano durante i pasti e nei momenti di attesa tra un trattamento e l’altro. Mi si avvicinava sciorinando tutti i possibili luoghi comuni dell’antisemitismo. Mi meravigliavo di come riuscisse a superarsi esibizione dopo esibizione. All’inizio ero sbalordito. Poi è arrivato il fastidio e infine la rabbia, ma la mia saggia moglie mi ha consigliato di non fare nulla. “Non rispondere. Se lo fai non libererai l’Asia centrale dagli stereotipi razzisti, ma di sicuro mi rovinerai la vacanza”. Forse Bulat sarebbe stato semplicemente divertente, se Sacha Baron Cohen non avesse mai inventato il personaggio di Borat.
Le veementi esibizioni antisemite del contadino kazaco hanno raggiunto l’apice l’ultimo giorno della vacanza. Mentre ero seduto sotto una coperta con degli elettrodi attaccati alla schiena e una guaina di cera calda sul torso (non chiedetemi perché, compagni, non ho risposte) ho dovuto sopportare Bulat che spiegava alle infermiere georgiane come i banchieri ebrei uccisero Gesù per rubare i nomi dei profeti musulmani.
Quella sera a cena Oleg, un russo sulla quarantina con la parte superiore del corpo particolarmente muscolosa, mi ha educatamente chiesto cosa pensassi dell’ultimo botta e risposta tra il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Joe Biden. Perché mai – ha chiesto – Biden non ha reagito più amichevolmente agli inviti al dialogo di Putin? Mi sono lanciato in una disquisizione sullo stato delle relazioni russo-americane, fin quando ho intravisto il tatuaggio che faceva capolino da sotto la manica della camicia del mio interlocutore. “Eri un paracadutista?”, ho chiesto cautamente. Il piglio sostenuto di Oleg si è subito sciolto in un sorriso compiaciuto. “Mvd, ministero dell’interno, 98° divisione. Come noi nessuno”, ha risposto con orgoglio. Era ovvio che l’argomento andava immediatamente abbandonato.
Mia moglie mi ha dato una forchettata su un ginocchio, sussurrandomi in francese che era lì per rilassarsi e che se la cena si fosse conclusa con discussioni sull’appartenenza della Crimea avrebbe ucciso sia me sia Oleg. Ho ubbidito con riluttanza e nei giorni seguenti io e il paracadutista abbiamo limitato le nostre conversazioni al tema universale e apolitico delle donne. ◆ nv
Vladislav Davidzon è uno scrittore e traduttore russo-statunitense. È il direttore della Odessa Review.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1418 di Internazionale, a pagina 108. Compra questo numero | Abbonati








